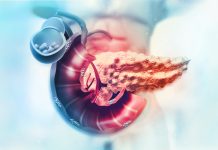Roma, 30 agosto 2024 (Agenbio) – Un team di ricercatori internazionali, di cui ha fatto parte anche l’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-Ismar), ha condotto uno studio per analizzare le tracce dell’impatto dell’asteroide che causò l’estinzione dei dinosauri circa 66 milioni di anni fa. L’obiettivo della ricerca era comprendere meglio l’origine dell’asteroide e il suo impatto sul nostro pianeta. I ricercatori hanno analizzato campioni provenienti dal strato che segna il confine tra il Cretaceo e il Paleogene, un periodo che ha visto l’ultimo grande evento di estinzione di massa sulla Terra, durante il quale oltre il 70% delle specie animali e vegetali si estinse.
Secondo una teoria ampiamente accettata, l’estinzione di massa del Cretaceo-Paleogene (K-Pg) fu causata dall’impatto di un asteroide di oltre 10 km di diametro, che colpì la Terra nella zona di Chicxulub, in Messico. L’impatto fu così potente da vaporizzare sia l’asteroide che parte della crosta terrestre. Le particelle di polvere risultanti da questa esplosione si dispersero nell’atmosfera, raggiungendo la stratosfera e oscurando la luce solare, il che impedì la fotosintesi per anni, portando a un drastico cambiamento nelle condizioni ambientali. La natura e l’origine dell’asteroide che causò questo evento catastrofico sono stati oggetto di discussione per anni, ma lo studio ha fornito nuove risposte.
Le particelle di polvere derivate dall’impatto si ritrovano oggi in uno strato di argilla noto come limite Cretaceo-Paleogene (K-Pg). Questo strato, visibile in numerose località terrestri, è caratterizzato da un’alta concentrazione di elementi appartenenti al gruppo del platino, come osmio, iridio, rutenio, platino, rodio e palladio. Questi elementi sono molto più abbondanti nel materiale proveniente dall’asteroide, rispetto a quanto presente nelle rocce terrestri, dove normalmente sono rari. Utilizzando una tecnica analitica innovativa basata sui rapporti isotopici del rutenio, un elemento del gruppo del platino, il team di ricerca ha dimostrato che l’asteroide di Chicxulub si è formato nelle regioni più esterne del Sistema Solare.
Mario Fischer-Gödde, dell’Università di Colonia e primo autore dello studio, ha spiegato che la composizione isotopica dell’asteroide che ha colpito Chicxulub è identica a quella dei meteoriti carbonacei, che sono frammenti di asteroidi di tipo C provenienti da oltre l’orbita di Giove. Questo confronto è stato possibile grazie all’analisi dei campioni di rutenio, che hanno rivelato dettagli sulla composizione dell’asteroide. Il team ha anche studiato altri crateri terrestri e strati di materiale espulso da impatti di asteroidi di diverse epoche. I dati raccolti mostrano che, negli ultimi 500 milioni di anni, la maggior parte degli impatti sulla Terra è stata causata da asteroidi di tipo roccioso (di tipo S), che si sono formati all’interno del Sistema Solare, mentre l’asteroide di Chicxulub è stato un raro esempio di asteroide di tipo C.
Alessandro Bragagni, ricercatore del CNR-Ismar e coautore dello studio, ha sottolineato che l’asteroide che ha colpito Chicxulub è l’unico grande esempio di asteroide di tipo C individuato nell’ultima storia geologica della Terra. Trovare altri asteroidi simili richiederà probabilmente un ritorno a periodi molto più antichi della storia geologica del nostro pianeta. Le tracce di tali eventi, infatti, sono visibili in carotaggi di rocce che risalgono a miliardi di anni fa. Questo studio fornisce quindi nuove evidenze sulla composizione dell’asteroide che ha avuto un impatto così devastante sulla vita sulla Terra e contribuisce a comprendere meglio l’origine dei corpi celesti che colpiscono il nostro pianeta. (Agenbio) Eleonora Caruso 9:00